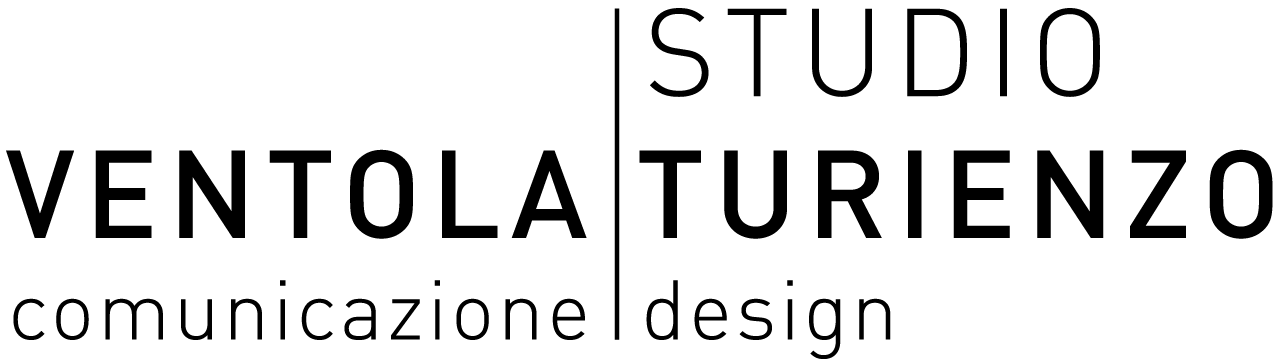Testo: A. Ventola | Fotografie: E. Turienzo | Editore: Syndicom | Data: 17 maggio 2013 | PDF
Il viaggio alla scoperta delle tecniche di stampa asiatiche prosegue. Dopo la magica Indonesia ci spostiamo in Australia. Incuriositi dalle pitture primordiali che troviamo lungo il cammino, entriamo in una delle comunità dove gli aborigeni esprimono la loro passione per l’arte.
L’arrivo in Australia è scioccante.
A Darwin dormiamo in ostelli affollati da ubriaconi e nomadi in cerca di fortuna.
L’Asia non potrebbe essere più lontana.
Dobbiamo andarcene.
Investiamo gli ultimi risparmi nell’outback. Noleggiamo un camper e partiamo. Da Darwin a Perth. 5000 chilometri di natura selvaggia, tramonti da favola e cieli stellati. Vino in cartone e carne di canguro.
La prima tappa è il Kakadu National Park. Qui abbiamo la possibilità di ammirare alcune delle più antiche pitture rupestri del Paese. Quelle che ammiriamo sono principalmente scene di caccia, vita quotidiana e rappresentazioni di spiriti.

Le pitture primitive esprimevano messaggi spirituali, religiosi e mitologici legati al dreamtime, l’epoca antecedente al big bang. Predominano storie volte a spiegare l’origine del mondo, insieme alle rappresentazioni di archetipi, simboleggianti la morale della comunità.
L’arte non aveva però solo scopi aulici. Le pitture servivano anche per marcare il territorio, avvisare gli altri clan che la zona era già occupata.
Inoltre, la pittura era l’unico mezzo di comunicazione fra le diverse tribù.
Oggi i clan sono ancora presenti e vivi sul territorio, nonostante l’arrivo dei colonialisti abbia progressivamente emarginato gli abitanti originali del continente. Gli aborigeni che non vagabondano per le strade si riuniscono in piccole comunità che si preoccupano di mantenere vive le tradizioni secolari.
Dopo diverse porte sbattute in faccia, alla fine di un pomeriggio passato su strade deserte, per caso troviamo la Laarri Gallery, all’interno della scuola aborigena Yiyili, a 120 km da Halls Creek.
Qui ci accoglie Annette, la ragazza tuttofare che guida lo scuolabus.
Annette conosce il linguaggio degli aborigeni. Ci spiega che l’aspetto estremamente moderno della grafica aborigena è dovuta alla prospettiva. La visione del territorio è duplice: aerea e a strati. Alcuni elementi sono dunque in sezione, come gli alberi, che si riconoscono dalla sezione circolare del tronco; lo stesso terreno viene sezionato per mostrarne il contenuto. Questo stile è chiamato “a raggi X” ed è affiancato dallo stile “dot art” (a punti). Quest’ultimo, che è attualmente il marchio di fabbrica dell’arte aborigena moderna, nasce nel 1973, quando l’insegnante d’arte Geoffrey Bardon incoraggiò gli aborigeni di Papunya a dipingere le loro storie legate al dreamtime, con lo stile che già utilizzavano per disegnare sulla sabbia. I punti sono equidistanti e di diversi colori. Le opere della dot art appaiono astratte, ma in realtà si avvalgono di un complesso simbolismo in cui a diverse forme base sono assegnati significati ben precisi. I simboli sono immagini stilizzate dell’oggetto in questione, o di una sua orma sulla sabbia, visto dall’alto.
I materiali tradizionali impiegati nella pittura aborigena erano acqua
o saliva mescolate con ocra e altri coloranti minerali, sangue di
canguro, resine o grasso animale. Oggi si preferiscono i colori acrilici. Per dipingere si usano pennelli, bastoncini, o le dita stesse.
Nell’atelier lavora Margaret Cox, un’artista aborigena di fama internazionale del clan Nanggadi. Margaret è meno timida rispetto ai suoi compagni, i quali abbassano spesso lo sguardo e faticano a rapportarsi con gli sconosciuti. Margaret è una pittrice in acrilico su tela e incide oggetti in legno. Il suo linguaggio è il Gooniyandi. Accetta di farsi fotografare, ma solo in compagnia dei propri figli.
Il nostro tempo è quasi scaduto e fuori, sullo sterrato, il camper impolverato aspetta. Salutiamo Margaret e Annette e attraversiamo il cortile dove i bambini giocano a rincorrersi e alcuni aborigeni chiacchierano tranquilli all’ombra di un tetto.

L’atmosfera è serena, e anche se siamo lontani da casa non ci sentiamo stranieri. Anzi. Siamo stati accolti come membri della comunità. Come se anche nel nostro DNA ci fosse un po’ di quel disagio, di quella sensazione di smarrimento.
Un po’ di quell’arte primordiale che serve a ricordarti chi sei. Che serve a farti volare e osservare le cose dall’alto.
Liberi come uccelli.