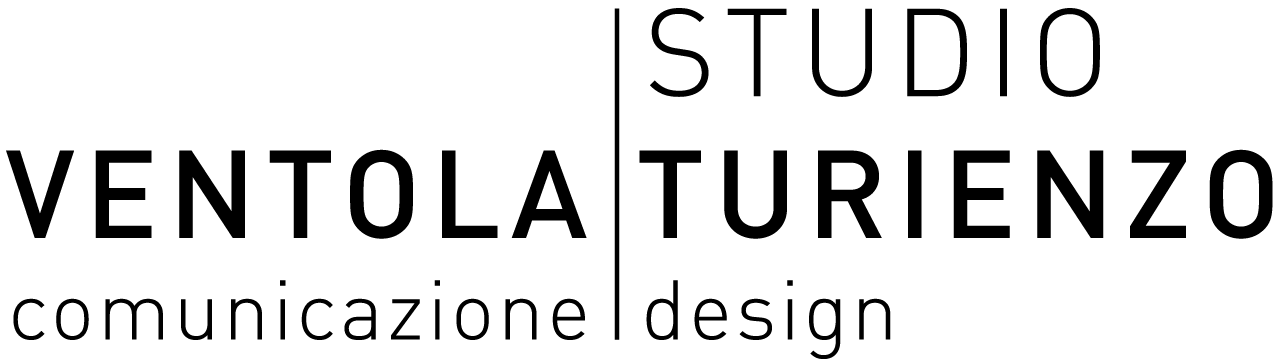Testo: A. Ventola | Fotografie: E. Turienzo | Editore: Rivista di Lugano | Data: 01 marzo 2013 | PDF
Il viaggio alla scoperta di stampatori e calligrafi continua. Con il cuore spezzato abbandoniamo l’Australia, che ci ha abbracciato con il suo amore spropositato, e torniamo nel cuore del viaggio, in Cambogia, terra sfruttata e violentata e uccisa e risorta, simbolo del coraggio di un popolo mai arreso.
C’è sempre quella scossa elettrica, quel brivido di eccitazione e godimento, quella scarica di adrenalina che parte dalla spina dorsale, quando lo speaker dell’aeroporto comunica che l’imbarco è cominciato.
Sul volo Ak1474, con le hostess perfette che svolazzano tra i sedili, le risatine isteriche dei passeggeri, la prassi del decollo, i flap che gradualmente si ritraggono prima di giungere alla velocità da crociera, i ricordi che lentamente sfumano e si confondono alle nuvole bianche, al momento del passaggio cruciale da un continente all’altro, nell’istante in cui ci solleviamo da terra, sul volo Ak1474, ci stringiamo le mani e ci guardiamo negli occhi, senza parlare.
Phnom Penh ci risucchia appena mettiamo piede fuori dal caos controllato della dogana.
È strano, dopo aver lavorato e vissuto in un altro mondo, riottenere quella capacità di adattamento che il viaggio richiede.
È strano perché appena rientriamo in Asia, è come se non ce ne fossimo mai andati. Nonostante siamo in Cambogia, il clima è sempre quello. Gli autisti di tuk tuk fischiano da un lato all’altro della strada, baracchini ad ogni angolo vendono cibo da asporto, motociclette arrugginite convogliano in massa verso l’unico semaforo senza nemmeno sfiorarsi, l’aria afosa e densa della città aspira la vita stessa dei suoi abitanti.
“Bentornati in Asia” sembra dire ogni sorriso beffardo, ogni viso angelico e innocente che incrociamo lungo la strada che porta alla guesthouse.
Il Lazy Gecko ci accoglie con una stanza da dieci dollari, connessione wi-fi e toilette in camera. Stanchi e affamati, dormiamo per la prima volta dopo centoventi giorni in un letto normale. Un manifesto contro la pedofilia, appeso alla parete della stanza, è l’ultima cosa che ricordo prima di staccare la spina.

Quando riapriamo gli occhi Phnom Penh non ha cambiato faccia. È sempre brulicante e ansimante, ansiosa di inghiottire anche te, farti fare un giro per le sue vie, come se fosse lei a pilotarti, a scegliere, facendoti credere il contrario.
Il museo nazionale è la prima tappa. Statue rappresentanti la civiltà Khmer testimoniano una presenza di vita antichissima, risalente agli albori dell’umanità. La religione buddista si respira ovunque, e il tatuaggio che ho del bodhisattva mi regala un minimo di notorietà tra i locali. La curiosità dei cambogiani è insaziabile, e presto capiamo il perché.
Al Choeung Ek Memorial, meglio noto come “I campi della morte”, a 15 km dalla città, passeggiamo tra le fosse comuni indossando un paio di cuffie, ascoltando la storia del genocidio perpetrata dagli Khmer Rouge, i soldati al servizio del dittatore Pol Pot, che instaurò un regime del terrore lungo quattro, sanguinosissimi anni.
Più di tre milioni di persone furono uccise in nome di una folle utopia: tra il 1975 e il 1979 Pol Pot sacrificò un terzo del suo popolo per creare una nuova generazione di cambogiani, una stirpe eletta che avesse i suoi profeti nella classe contadina. Una dittatura del proletariato che causò lo sterminio di tutti coloro i quali non lavorassero la terra, ma fossero di rango più elevato. La paranoia omicida di Pol Pot non risparmiò nessuno tra avvocati, medici, funzionari pubblici, insegnanti, monaci, donne e bambini. Tutti furono sacrificati nell’enorme falò di carne chiamato Anno Zero.
Passeggiamo tra le fosse, attoniti e in silenzio. Fermi, insieme a decine di altri visitatori, fissiamo un albero, uno dei tanti, vicino a una fossa dalla quale sbucano resti di ossa, brandelli di stoffa e denti. L’albero è adornato di braccialetti e ciondoli. Quando i primi ad arrivare sul luogo delle esecuzioni lo trovarono, la sua corteccia era coperta di sangue. Gli scopritori non capirono il motivo, fino a quando non videro resti di cervella ai suoi piedi. Pol Pot sapeva che prima o poi qualcuno sarebbe tornato a gridare vendetta. Così, per cancellare ogni dubbio, nelle calde notti di metà anni Settanta, coperti dagli altoparlanti che intonavano inni e canti propagandistici, gli Khmer Rossi afferravano i neonati per le gambe e davanti alle madri li schiantavano sul tronco. Le guardie che sbattevano i nascituri come polli, fino a fargli esplodere il cranio, superavano di rado i tredici anni.
La visita termina nello stupa, l’edificio commemorativo di matrice buddista, dove sono conservati ottomila teschi, dai quali si possono desumere le tecniche di tortura usate.
Uscendo dai campi di sterminio, la sensazione è quella di trovarsi faccia a faccia con le conseguenze del genocidio. Non occorre essere degli acuti osservatori per rendersi conto che l’età media del popolo cambogiano supera a malapena i vent’anni. I figli del massacro, una generazione di orfani a cui è stato tolto tutto, a partire dall’istruzione, conoscono solo ciò che vedono e le loro possibilità sono dannatamente limitate.
La corruzione dilaga in Cambogia, tutto ha un prezzo. Metà della popolazione femminile si prostituisce. Passeggiamo adocchiando uomini di mezza età dal sorriso marcio che accarezzano principesse bambine, cintano loro la vita con un braccio, come piante rampicanti che cercano di intrappolare fiori appena sbocciati, strappandone i petali con le spine aguzze, fino a quando del fiore non rimane niente, solo il profumo.
Da Phnom Penh a Battambang, città costellata di templi collinari e grotte della memoria, allevamenti di coccodrilli e ponti sospesi che collegano un villaggio all’altro, vigneti e sciami di pipistrelli, custodi di segreti e maledizioni ultraterrene.
Da Battambang proseguiamo verso Siam Raep, dove abbiamo un contatto che ci introduce alla città più popolare della Cambogia. Siam Reap è un piccolo gioiello, incastonata tra il lago di Tonlee Sap e i meravigliosi templi di Angkor Wat, il più grande luogo di culto al mondo, reso famoso dalla pellicola di Tomb Raider. Alberi immensi, dai rami svettanti alti verso il cielo, come fossero stati piantati su trampoli, circondano le pietre scabre delle rovine con le radici annodate e nervose, come serpi indemoniate, mentre la strada fende in due l’orizzonte, un fiume di polvere diretto verso il mare. Stormi chioccianti di turisti occupano cornicioni e bocche di pietra, sotto gli occhi immobili delle divinità khmer, che li giudicano un’offesa alla luce del sole, un rimprovero al cielo vuoto, una macchia di nebbia sul vigore, concentrato e deciso, del rude paesaggio.
Tra fumate di nepalese e partite a biliardo nei locali notturni della città, muoviamo verso Sihanoukville, triste e deprimente località marittima, prima di giungere all’ultima tappa cambogiana, la suggestiva città di Kep.


In attesa di balzare sul traghetto, destinazione Vietnam, rilassiamo le membra in questa piccola oasi senza tempo.
La vita scorre lenta e nessuno sembra interessato al passato. Il mare sembra avere un altro colore qui, e le sue onde paiono cullare i figli di una terra rossa di rabbia, e sembrano carezzargli l’anima, cicatrizzarne l’orrore, e promettere un’idea di speranza, che a guardare l’orizzonte durante le prime luci dell’alba, non sembra neanche troppo lontana.
Andrea Ventola