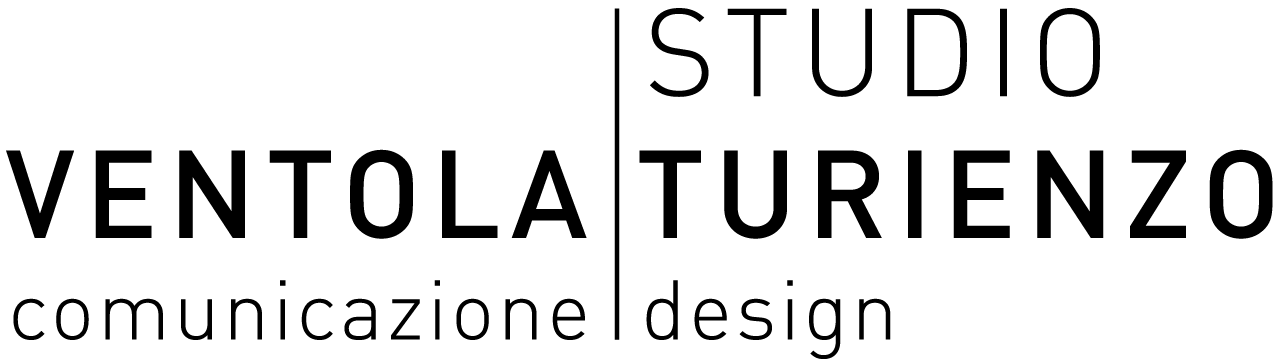Testo: A. Ventola | Fotografie: E. Turienzo | Editore: Rivista di Lugano | Data: 13 luglio 2012 | PDF
Il nostro viaggio in Asia, alle scoperte delle tecniche di stampa, continua. Dopo India e Giappone approdiamo in Corea, Myanmar e Thailandia. L’Oriente è sempre più affascinante e sconvolgente per la generosità e la tenerezza con le quali ci accoglie.
Rewind. Riavvolgere il nastro. Ora che ho di nuovo i capelli corti e sorseggio un cocktail di frutta tropicale, il sole che crolla lento all’orizzonte, il mare azzurro che circonda l’isola di Ko Tao e armate di turisti che crogiolano sulla spiaggia bianca come cetacei spiaggiati, mi rendo conto che non riesco a mettere a fuoco. Questa è la nostra terra, ora. Nessuno zaino sulle spalle, nessuna pioggia, nessuna corsa per agguantare l’ultimo treno, nessuna dissenteria, nessuna turbolenza, nessuna infezione. Nessuna povertà estrema, nessun pickup che accelera nell’alba mentre sei appollaiato sul tetto con una mano a tenere i bagagli e l’altra a fare il segno della croce. Nessuna fatica. Nessuna sensazione di smarrimento. Nessuna paura. C’è solo il mare, la musica reggae e il profumo della pizza appena sfornata. Le bionde alla spina, le barche dei pescatori che ondeggiano tranquille. La pace galleggia nell’aria, soffice come una nuvola di zucchero. Ma questo è solo ora. Prima c’è altro. E i ricordi affiorano in superficie, si fanno largo a spallate nel campo della memoria, non si lasciano domare dalle briglie con le quali cerchi di ordinare le idee. Siete di nuovo a bordo del traghetto che sfida i cavalloni accelerando ad ogni scossa di mare, le urla dei coreani impazziti che scommettono su entro quanti minuti andrete a fare compagnia ai pesci, e fuori dall’oblò c’è solo un deserto blu che spruzza schiuma bianca, il Giappone che si allontana e la terra che non si vede e non si sa bene quanto manca all’arrivo.
C’è Busan, dove la precisione dei giapponesi è sostituita dal caos impazzito dei coreani, i clacson suonati solo per animare la strada e l’allegria contagiosa degli anziani, vestiti con abiti eleganti anni ’20, la coppola e il mozzicone arrostito fra le dita, personaggi sbucati da un tempo dimenticato che giocano a scacchi e insistono per una foto con la ragazza straniera. Le immagini ritornano alla memoria sfocate, come diapositive rimaste in soffitta per troppo tempo. Ma altre ci sono. Vive. E brillano di luce propria come le canzoni dei Jet. La faccia del tatuatore reduce da una sbronza di Jägermeister, per esempio, che si sciacqua la faccia per dieci minuti prima di inciderti un Buddha sulla spalla senza perdere la concentrazione. I motel economici nei quartieri a luci rosse, le camere da letto illuminate da soffuse luci al neon, lenzuola macchiate e cuscini imbottiti di peli, le urla di godimento che suonano in coro dalle altre stanze. Mr. Jung Kwan-Chae, con il suo stupendo atelier nella campagna di Naju, i tessuti color indaco protetti dall’Unesco, che vi invita a cena e poi vi porta al supermercato in piena notte per comprarvi la colazione. O la donna che vi raccoglie in autostop e vi offre il pranzo – panino e bottiglia di latte – solo perchè siete “ospiti” nel suo Paese. O i templi, nei quali regna la pace sacra della preghiera, e le chiese che incontrate lungo il cammino – alcune colorate e allegre, altre spoglie ed essenziali – dove vi ricaricate lo spirito prima di continuare.


Ma la Corea svanisce in fretta, le diapositive si sovrappongono e vi ritrovate a Yangon, in Myanmar, dentro un hotel fatiscente, camera senza finestre e muri diroccati, coppie di gechi che sbucano dalle crepe a caccia di insetti, una latrina che rigurgita riso fritto e uova, nessuna connessione e il sudore ghiacciato che cristallizza sui vestiti sporchi.
Il Myanmar è un ritorno a casa. È un ritorno all’India. La prima tappa del viaggio, quella che più è rimasta nel cuore. Almeno, fino al Myanmar. L’ex Birmania è un ricordo recente, troppo bello e maledetto per essere dimenticato. Una terra tormentata dai dissidi politici. La vittoria di Aung San Suu Kyi ha cambiato le cose solo in parte. Ha dato una speranza, ma i militari hanno sempre il coltello dalla parte del manico. Per otto ore al giorno l’elettricità viene tagliata. Giusto per far capire chi comanda. Aver votato la Lady implica delle conseguenze. Niente luce. Le strade si spengono, i lampioni smettono di scintillare. Come una festa interrotta bruscamente dal padrone di casa. Rimangono solo i generatori di corrente di qualche guesthouse e i fari delle macchine. Per il resto, è come se Dio avesse saltato il primo giorno. Come se si fosse dimenticato di accendere l’interruttore. La luce è appannaggio dei militari. Al popolo è rimasto il fuoco. Un fuoco che brucia l’anima dei birmani e li fa parlare, a rischio della propria vita. Questo senso di guerra continua, invisibile, oltre al fatto di trovarsi in una terra ancora incontaminata dal turismo di massa, crea un alone elettrico intorno al Myanmar, una cortina di amore rabbioso che non si piega al volere dei dittatori. La vallata dei templi nella città di Bagan – il tramonto rosso che scivola dietro una foresta di palme, le migliaia di Buddha in pietra che proteggono i suoi abitanti – è uno spettacolo al quale l’occhio umano non si abituerà mai. Qualcosa di epico esplode nell’aria, un rumore silenzioso di tamburi ribelli che forgia lo spirito e riempie gli occhi di lacrime asciutte, mentre rimani da solo con questa stretta che ti affossa la voce e ti impedisce di parlare.


Il Myanmar è incollato alla Thailandia, lo stesso sole furioso che appiccica la maglietta al torace, le stesse meraviglie da assaporare senza pensare troppo. Solo lo spirito è diverso. Il Myanmar è ingenuo, puro e povero. E ha fame di rivalsa. Con la vittoria della Lady si è aperto al mondo. I birmani vogliono trasformare il Paese in un’attrattiva turistica, vogliono bruciare le tappe ed emulare la Thailandia, saltare sul carro dei vincitori e riscuotere la loro dose di successo. Turisti, soldi, fascino. Ma la Thailandia è navigata, basta guardarsi intorno: un mondo patinato, costruito ad hoc per l’invasore occidentale. Un parco giochi nel quale la tradizione è nascosta, sotterrata in attesa che l’alta stagione finisca e i turisti ritornino alla vita di tutti i giorni, con una bella cartolina impressa nella memoria. La Thailandia non ha bisogno di presentazioni. È nel giro da decenni, muta forma a seconda dell’occorrenza, usa sapientemente le informazioni dettate dalla Lonely Planet. La legge del commercio viene rispettata alla lettera e non si fanno sconti.


Sorseggi la tua birra in riva al mare, il giocoliere lancia pire infuocate nel cielo rosso del tramonto, sulla griglia arrostiscono spiedini di calamari e il costume bagnato riposa sulla sabbia. Questo è il tuo mondo ora, e le persone che hai incontrato – il prete di Mandalay che assisteva i malati, la guida con il morso del cobra sulla gamba, il tassista anarchico, il sigillatore coreano amato dalla regina Elisabetta, il pittore inglese apprendista stregone, il vagabondo australiano guidato dalle sostanze allucinogene – sono tutti fumetti astratti che si confondono con i sogni notturni, lucciole che lampeggiano nelle tenebre di un vicolo scuro, e non sai bene se quegli incontri li hai fatti davvero o se sono il frutto della tua fantasia.
Il mare di Ko Tao è davanti a te. Il giocoliere spegne le pire.
Ma il fuoco continua a bruciare.
Andrea Ventola