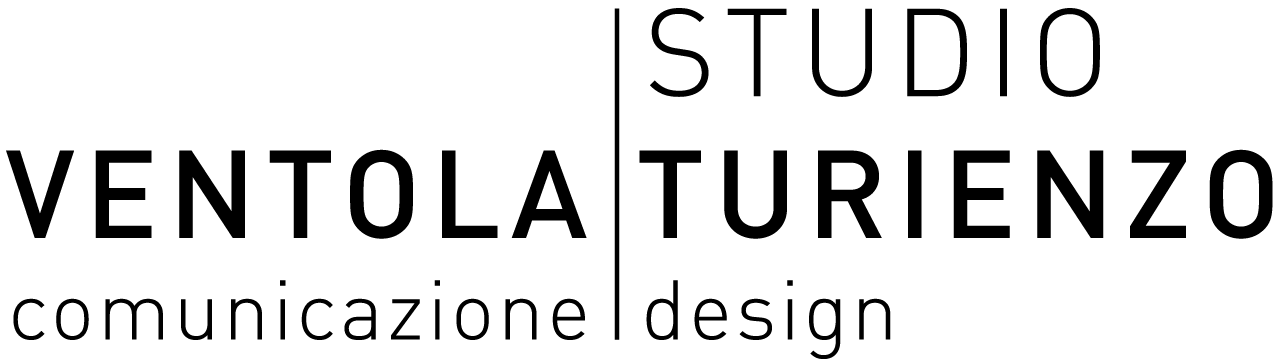Testo: A. Ventola | Fotografie: E. Turienzo | Editore: Rivista di Lugano | Data: 23 marzo 2012 | PDF
Inghiottito nel vortice del caos, ricalcolare le traiettorie di viaggio, le aspettative e le promesse della strada. Quando credi di aver risolto tutto il destino rimescola le carte, il croupier dà un effetto strano alla pallina, le luci e i colori ruotano tutt’intorno a te mentre provi a scendere dalla giostra, mentre cerchi di respirare a fondo, mentre salti da una roccia all’altra, provando a restare in equilibrio sopra il baratro.
L’arrivo a Mumbai è un colpo secco di machete, il vento caldo disperde l’odore di spazzatura bruciata e gas di scarico, ti sembra di masticare il catrame, una polpetta di veleno incastrata in gola. I tassisti sono pazzi suicidi a bordo dei loro rickshaw – semplici Api Piaggio barcollanti che schiodano fra autocarri e Honda Hero, gli zaini che spostano il peso sbilanciando la vettura carica.
Mumbai è un formicaio, il 55% della popolazione non raggiunge la soglia minima della sopravvivenza. È una metropoli sdentata. La Porta d’Oriente sdogana il Mar Arabico, turisti che scattano foto all’impazzata e mendicanti che ti assillano per un tozzo di pane. La nostra scorta di banane e pane al burro ci permette di non svenire sotto il sole, giallo come i denti del vecchio sadhu che prega seduto sopra i vapori di un tombino. L’acqua in bottiglia si surriscalda dopo pochi minuti, le gambe si sciolgono e il cervello ronza a vuoto, piroettando tra il rumore incessante di clacson famelici e urla, voci e occhi scuri come la notte. Victoria Station è un festival di mentecatti e mutilati, grassi banchieri abbronzati e sari arcobaleno, bambini-gazzelle che saltano e corrono attraverso i binari fatiscenti, i treni senza porte che si vedono rincorrere da branchi di carne umana. Camminare per le strade di Mumbai equivale a scivolare sopra un rasoio elettrico. Sotto il cemento bollente si nascondono le percezioni di un dio Jainista, la ruota del karma vortica sopra i 20 milioni di abitanti, scintillando ed esplodendo al ritmo di preghiere metropolitane, un tam tam di litanie ipnotiche che scivolano nella pancia della città, il dio-piovra che inghiotte e sputa e manovra i suoi tentacoli verso l’alto. Mumbai è il campo base. Assaltiamo un autobus scalcagnato, le cinghie degli zaini strette fra i denti, come pirati pronti all’arrembaggio. Destinazione Vadodara. L’autobus ha gli ammortizzatori disintegrati, la testa vibra per dodici ore consecutive, la vescica tiene duro. Proviamo a respirare affondando la faccia nella maglietta, la mancanza di ossigeno si mescola alla polvere del loculo che ci hanno assegnato, l’odore di calzini bagnati e urina accompagna il nostro pasto frugale, di tanto in tanto fumo una Gold Flake per ammazzare l’attesa. Sbagliamo fermata. Passiamo Vadodara e dobbiamo fermare ad Ahmedabad, tra indiani che premono per ospitarci e tassisti ubriachi desiderosi di spennarci. Ahmedabad è mezza musulmana, trovare una goccia d’alcool è praticamente impossibile. Ci addentriamo nelle viscere della città, alcuni ragazzi insistono per farci vedere il loro tempio di famiglia dedicato a Shiva il Distruttore. Scattiamo un po’ di foto ricordo ai ragazzi e ai loro famigliari, bambine bellissime che scorrazzano a piedi nudi sulla terra calda, la nonna ammantata nel suo velo dipinto a mano, il capofamiglia che ci porge due tazze di chai fumante, ci invita a berlo e a raccontargli del nostro viaggio. I ragazzi vogliono giocare a cricket, io insisto per una partita a calcetto sei contro sei, ma alla fine subentra un ex attore di Bollywood che a quanto pare è il capo quartiere, e insiste per un tour gastronomico tra viuzze randagie e vacche sacre che masticano annoiate i loro stessi escrementi. Non riusciamo a pagare nulla, la generosità del capo è imbarazzante. Trangugiamo qualsiasi cosa ci venga data. Riesco a offrire delle sigarette, ma di soldi non se ne parla. Siamo ospiti.

Il Gujarat è una regione arida, polverosa, poco battuta dal turismo di massa. Palitana, ad esempio, è il classico villaggio da Far West, col vento che spazza la sabbia cocente sui volti coperti da fazzoletti. Si vedono solo occhi che scrutano lo straniero, occhi curiosi e limpidi come la neve del Kilimangiaro, occhi che ti si incollano alla schiena mentre accompagni il passo stanco verso la valle dei templi.
Palitana è uno sputo nel deserto, una sosta obbligata per i pellegrini diretti verso la collina di Shatrunjaya, una delle mete piu’ sacre di tutta l’India. La dissenteria ci inchioda alla latrina la prima notte. Riempiamo secchi d’acqua da usare come sciacquone. Il mattino dopo ci laviamo con gli stessi secchi. L’acqua gelida è un toccasana per lo spirito. Acquistiamo biscotti e pane. Ci inerpichiamo sopra il colle, tremila scalini sotto il solleone di mezzogiorno, due folli armati di bambu` che salmodiano all’unisono un mantra di protezione dell’intestino. I templi sono magnifici, i polpacci sono gonfi e la gola è secca da far paura. Abbiamo già perso diversi chili. In India il cibo è prevalentemente vegetariano. Poca sostanza, molti liquidi.
La polvere di Palitana si allontana dal bus statale che divora il terriccio fangoso, verso la roccaforte portoghese di Diu, un paradiso per turisti inglesi in pensione che vogliono solo godersi il mare e la birra ghiacciata che servono da quelle parti. Diu non è propriamente India. È un’ex colonia portoghese, i colori rossi e verdi si riflettono nei sari indossati dalle donne indiane, e nei mattoni delle case piccole e graziose che scendono in corteo fino alla spiaggia. Ci godiamo qualche pasto decente all’O’Coqueiro, mentre i latrati dei cani avvizziti e ossuti si spiegano alla luna come vele bucate da colpi di cannone, si spengono rancidi per le vie male illuminate, e ti sale anche un po’ di paura a camminare nell’oscurità, sapendo che da un momento all’altro un dingo affamato potrebbe azzannarti una gamba. Diu è molto turistica e poco indiana. Odio tutti quelli che incontro, litigo con un vecchio che gestisce un chiosco di sigarette. Non sopporto nessuno, ma cerco comunque di riposare e di godermi il sole. Quando lo stomaco è abbastanza preparato ci rimettiamo in marcia, pieghiamo verso Nord, a Bhuj, dove incontriamo alcuni artigiani del tessile. Mohammad Khatri è un genio visionario che ha dedicato una vita alla stampa e alla colorazione di stoffe pregiate. Mangiamo a casa sua, dopo aver girovagato per i campi deserti, vasche d’acqua usate per l’irrigazione degli orti e pannelli solari che generano la corrente necessaria a far funzionare il villaggio.
 Bhuj è davvero magica, con i suoi bazar zeppi di merci rare ed esotiche. Conosciamo alcuni backpackers, la sera ci scambiamo racconti horror nel buio del cortile della guesthouse, fumando tabacco essiccato e bevendo Thumbs Up tiepida. Abbandoniamo il Gujarat e ci dirigiamo verso il Rajastan, la regione indiana che piu’ si avvicina all’immaginario collettivo, con le tigri, le scimmie e gli elefanti, i santoni dagli occhi iniettati di sangue e i templi magici, donne che trasportano ceste di vimini sulla testa e sikh dai turbanti vistosi che si grattano la barba nera, odore di esotismo e turismo frenetico ovunque. Il viaggio dura venti ore, tra autobus sgangherati e treni cigolanti, facce sconosciute che sospirano nelle tenebre e chai servito all’alba. Udaipur è la Venezia d’India. Facciamo fatica a orientarci, ci sembra di vivere dentro un fumetto, dove ovunque ci sono europei e americani dalla faccia d’angelo, la pelle bianca, che scattano fotografie e contrattano sul prezzo di t-shirt commerciali e inutili. Vado in crisi mistica. I momenti passati nella moschea di Ahmedabad, mentre leccavo lo zucchero da terra e bevevo acqua sporca da una ciotola per purificarmi l’anima, sono lontani. Qui è solo business e “Hello, where are you from?” e il mio spirito è irrequieto, fumo Classic a ripetizione e mi spengo sulla terrazza della guesthouse, quando cala il sole e rimangono solo i dubbi. “Dove stiamo andando?” chiedo al riflesso nello schermo dell’i-Pad, ma fuori c’è solo il muezzin che urla angosciato a Dio, e io sono solo e fragile sotto una cupola di vetro nero che qui chiamano cielo.
Bhuj è davvero magica, con i suoi bazar zeppi di merci rare ed esotiche. Conosciamo alcuni backpackers, la sera ci scambiamo racconti horror nel buio del cortile della guesthouse, fumando tabacco essiccato e bevendo Thumbs Up tiepida. Abbandoniamo il Gujarat e ci dirigiamo verso il Rajastan, la regione indiana che piu’ si avvicina all’immaginario collettivo, con le tigri, le scimmie e gli elefanti, i santoni dagli occhi iniettati di sangue e i templi magici, donne che trasportano ceste di vimini sulla testa e sikh dai turbanti vistosi che si grattano la barba nera, odore di esotismo e turismo frenetico ovunque. Il viaggio dura venti ore, tra autobus sgangherati e treni cigolanti, facce sconosciute che sospirano nelle tenebre e chai servito all’alba. Udaipur è la Venezia d’India. Facciamo fatica a orientarci, ci sembra di vivere dentro un fumetto, dove ovunque ci sono europei e americani dalla faccia d’angelo, la pelle bianca, che scattano fotografie e contrattano sul prezzo di t-shirt commerciali e inutili. Vado in crisi mistica. I momenti passati nella moschea di Ahmedabad, mentre leccavo lo zucchero da terra e bevevo acqua sporca da una ciotola per purificarmi l’anima, sono lontani. Qui è solo business e “Hello, where are you from?” e il mio spirito è irrequieto, fumo Classic a ripetizione e mi spengo sulla terrazza della guesthouse, quando cala il sole e rimangono solo i dubbi. “Dove stiamo andando?” chiedo al riflesso nello schermo dell’i-Pad, ma fuori c’è solo il muezzin che urla angosciato a Dio, e io sono solo e fragile sotto una cupola di vetro nero che qui chiamano cielo.
Andrea Ventola