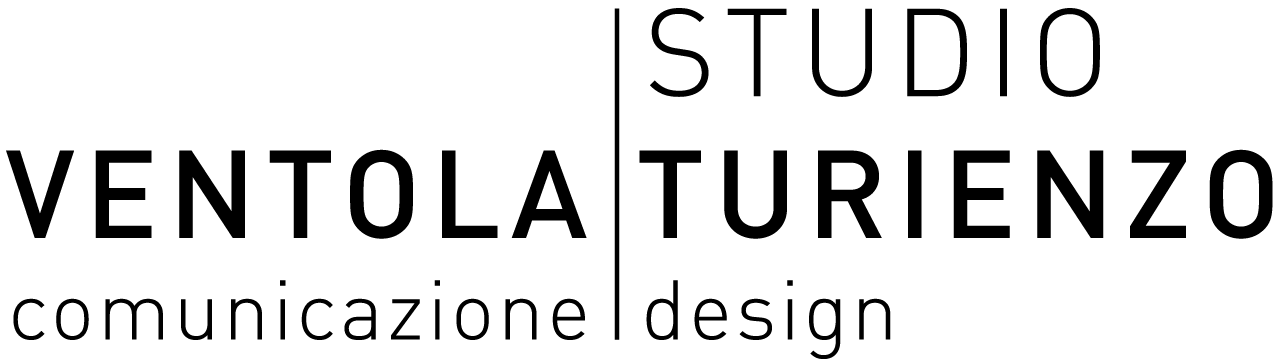Testo: A. Ventola | Fotografie: E. Turienzo | Editore: Rivista di Lugano | Data: 25 maggio 2012 | PDF
Il nostro viaggio zaino in spalla in asia, alla scoperta delle tecniche di stampa, procede a gonfie vele. Dopo essere stati in India, meta che ci ha dato molto più di quello che speravamo di trovare, attraversiamo il Giappone con l’obiettivo di scovare artigiani della carta stampata e analizzare le differenze culturali che intercorrono fra loro e noi.
Seduti a gambe incrociate sulla moquette soffice, a bordo di un traghetto giapponese, sperando che la carcassa galleggiante tenga botta, sperando che il mare non sia mosso come ieri – due ore di altalene e conati trattenuti, brutti pensieri che affioravano come alghe morte, preghiere silenziose nel mezzo del mar Giallo – e se tutto va bene saremo a Tsushima. Altra isola, altro giro di ruota. La Corea è sempre più vicina. Potremmo arrivarci entro oggi, sempre via nave. Il Giappone ce lo stiamo lasciando alle spalle, sono gli ultimi istanti di vita nipponica quella che stiamo assaporando. L’arrivo a Tokyo è lontano anni luce, sembra appartenere a un’epoca sepolta sotto strati di chilometri percorsi a piedi e bottiglie vuote di sakè, kimono strappati che penzolano nell’oscurità di un tempio buddista, geishe che sorridono ammaliatrici dietro una maschera bianca. Tokyo è lontana, ma è ricominciato tutto da lì. Dopo una falsa partenza, dopo che abbiamo bruciato lo start, ci siamo riposizionati sulla linea e abbiamo aspettato il colpo di pistola. E abbiamo ricominciato a correre, mescolati nel magma fluorescente della metropoli nipponica, un coacervo di suoni e insegne al neon, meraviglie architettoniche del periodo Edo e grattacieli di vetro eretti a idoli del consumismo, dolci case in legno profumanti di ginger e soia, ponti arcobaleno che proiettano autostrade da videogame, scenari apocalittici alla Blade Runner e silenziose sale da tè incuneate nel midollo spinale di un Giappone carico fino all’osso di tecnologia, scienza e religione. Tokyo è frenetica, l’adrenalina riempie i polmoni e ti scuote come un ratto bastonato nel bidone della spazzatura. Svegliati. Apri gli occhi. Sei in un mondo parallelo, tridimensionale e spaziale. Gli adolescenti che sguazzano nelle vie di Takeshita Street sono fumetti di carne: capannelli di acconciature cyberpunk e costumi inneggianti alla follia, corpi magri e nervosi, studentesse in guepierre e treccine che farebbero resuscitare Nabokov, revival di un mondo sotterraneo anni ottanta innestato dentro cervelli nerd calamitati dalle sale giochi Sega, Namco, Konami.

Siamo anche noi nel trip, presi all’amo come carpe, trascinate nel flusso inarrestabile della corrente modaiola. Da Tokyo veleggiamo verso Matsumoto, castello in legno emblema del Signore della guerra e artigiani che fabbricano penne a mano. Mangiamo tramezzini al tonno comprati al Family Mart e germogli di soia, un classico della nostra dieta nipponica. A Takayama incontriamo Arlow, una guardia aeroportuale canadese, e Cathrine, comandante svedese su una nave cargo, entrambi viaggiatori zaino in spalla. A Takayama c’è uno dei festival più importanti di tutto il Giappone, il Takyama Spring festival, una parata di carri e marionette karaku simboleggianti antiche divinità giapponesi. Divoriamo carne di manzo alla griglia e ci gustiamo lo spettacolo pirotecnico sotto una pioggia gelida, vento freddo che fa oscillare le lanterne rischiarando di luce intermittente le maschere demoniache.
Da Takyama finiamo a Kanazawa, dove abbiamo la netta percezione della purezza primaverile giapponese. L’Hanami, la fioritura dei ciliegi, è intensa al punto da dipingere di petali rosa il parco più bello di tutto l’Arcipelago, il Kenrouen. Il quartiere delle geishe è un tuffo nel passato, luci soffuse e risatine maliziose che scivolano oltre le pareti di carta. Incontriamo un artista esperto nella tintura dei kimono prima di spostarci a Echizen, un villaggio di artigiani. Kyoto è l’altra metropoli, la principale meta giapponese dei turisti di tutto il mondo, ma noi ne abbiamo abbastanza di mete turistiche. La visitiamo svogliati, fermandoci a bere cappuccino negli Starbucks del centro e conversando a basso volume con le persone che incontriamo. Da Kyoto a Nara (giusto per completare il trittico delle capitali) e poi a Osaka, dove la vita notturna ha il sopravvento sulla pallida luce del giorno, palazzi fatiscenti rimasti tali e quali dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, personaggi inquietanti popolano la metro come una tribù aliena che non sale mai in superficie, facce macchiate dalla luce artificiale dei sotterranei, ombre di spiriti inquieti oscillano sui sedili, occhi da rettile scrutano all’interno di cabine subacquee, sensazioni nefaste ricoprono la pelle di un prurito liquido e malsano…
La verità è che l’India ci manca. Sembra assurdo, ma è così. L’India era assenza di necessità. Non c’era bisogno di nulla. Un ritorno alla vita triviale, il tempo aveva perso la sua consistenza, la fretta non esisteva. Il Giappone per certi versi è simile. La calma e la profondità degli inchini, l’educazione maniacale delle persone che sono capaci di ringraziarti una decina di volte nell’arco di un minuto, il senso di ospitalità e di generosità, la pulizia e l’ordine assiduo… Tutto ciò riempie l’aria e ti entra dentro come un virus benevolo in grado di rilassarti e caricarti di energia. L’altro lato della medaglia sono le metropolitane stipate di corpi lucidi e perfettamente incastrati fra loro come un tetris umano, gli zombie sonnolenti in giacca e cravatta che marciano compatti verso le loro postazioni operative, lo stress da eccesso di lavoro, lo shopping come unica alternativa all’isolamento, il sesso fai da te e i suicidi «onorevoli». Ogni Paese ha i suoi scheletri nell’armadio, le sue virtù, uno spirito collettivo di unione e un senso di appartenenza che sono le vere forze motrici del progresso. Il Giappone ha una croce pesante da portare, un destino arcigno che più volte l’ha messo in ginocchio, una collezione di sfighe universali che avrebbero sepolto qualsiasi altro impero. Ma non il Giappone. Sarà questo senso dell’onore che si portano dietro come una belva ammaestrata, sarà che non hanno minimamente idea di cosa sia la paura, sarà che non si lamentano mai… Non abbiamo idea di quale sia la forza del popolo nipponico, ma sta di fatto che loro continuano a sorridere e a tirarsi su le maniche. Lavorano e costruiscono e seppelliscono i morti e ritornano a lavorare e a costruire e a progettare un futuro per le nuove generazioni. Questo è il loro credo, tra un inchino e un «arigato gozaimasu». La solidarietà dimostrata dal resto del globo per ciò che è successo nel 2011 sembra averli investiti di una luce nuova. Non sono soli, questo è il messaggio che traspare. E anche noi, attraversando l’arcipelago da nord a sud, ce ne siamo resi conto.
Andrea Ventola